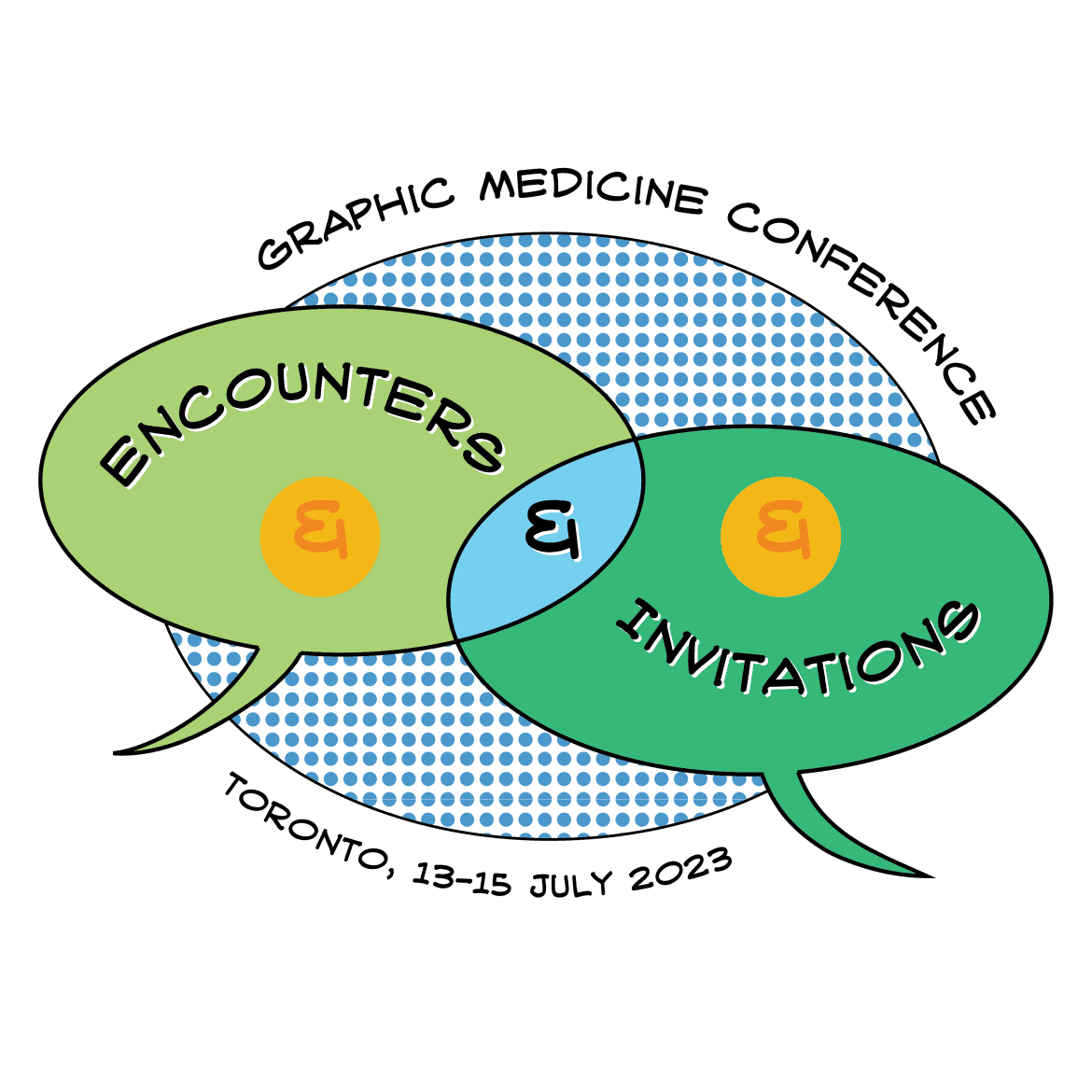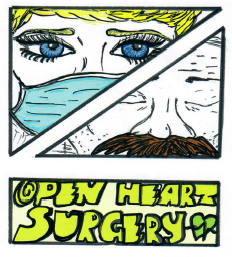La storia del topo cattivo, ora in edizione del trentennale per i tipi di Tunué, risale agli Anni 90. Il periodo d’oro per eccellenza del fumetto “mainstream”, con le grandi saghe super-eroistiche e la “bolla” dei milioni di copie vendute per testate come X-Men. Inaudito, per l’epoca, proporre al pubblico una storia dedicata agli abusi sui minori. Come ti è venuta l’idea inizialmente?
Sì, graphic novel oltre i generi come Maus di Spiegelman sono una proposta editoriale relativamente recente… ma con la loro uscita hanno dimostrato proprio in quel periodo che i fumetti potevano essere un ottimo veicolo per storie di ogni genere. All’inizio, pensavo di scrivere una storia sul Lake District inglese, tutt’altro tema rispetto agli abusi sui minori. Ma un giorno, passeggiando nella stazione della metro di Tottenham Court Road, a Londra, notai un’adolescente che elemosinava su un binario. Con suo grande fastidio, un grosso tizio barbuto membro di qualche setta evangelica stava cercando di convincerla a seguirlo in un ostello o da qualche altra parte. Sembrava così imbarazzata… Ripensando a lei qualche ora più tardi, mi venne in mente quello che si diceva su Beatrix Potter, che a quento pare all’età di 16 anni era “di una timidezza straziante”. In quel periodo, a partire dai suoi legami con quei luoghi, stavo facendo ricerche sulla Potter per il mio progetto sul Lake District. Cosi ho fatto due più due, quella alla stazione è diventata la prima scena del libro e da lì è nata tutta la storia. Mi sono detto “E se questa ragazza avesse una connessione con Beatrix Potter e seguisse le orme di Potter fino al Lake District?”. Mentre ci ragionavo, ho sentito la necessità di spiegare perché fosse scappata di casa. Così ho pensato “Perché suo padre abusava di lei”. Molti ragazzi scappano a londra da ogni angolo dell’Inghilterra per sfuggire agli abusi. Dato che non sapevo nulla sull’argomento, ho iniziato a documentarmi in libreria e in biblioteca, rendendomi conto ben presto che il tema degli abusi era troppo importante per essere “solo” uno spunto narrativo pet spingere la protagonista a scappare di casa. Doveva essere il tema portante del libro.
È stato difficile, a suo tempo, trovare un editore interessato al progetto?
È stata una vera impresa. Avevo inviato il proposal con il concept e qualche illustrazione di prova a tutti i principali editori di libri illustrati del Regno Unito, nella speranza di raggiungere un pubblico mainstream al di là del “ghetto” dei comic books. Era un fascicolo molto curato, stampato in 20 copie rilegate con tanto di copertina in acetato sopra la stampa della cover provvisoria e una lettera di accompagnamento: ma questo, ben prima del boom dei romanzi grafici e del fumetto in generale. La metà degli interessati non si sono nemmeno degnati di darmi una risposta. Quelli che lo fecero, rifiutarono la proposta senza neanche esaminarla, probabilmente piantando lì tutto alla prima comparsa della parola “fumetto” nella lettera di accompagnamento… A quel punto decisi di rivolgermi agli editori specializzati. La DC Comics rifiutò, ma il progetto aveva intrigato altre case editrici, in particolare Tundra. Nel febbraio del 1992, mi recai alla convention sui fumetti all’Alexandra Palace di Londra deciso a trovare un editore. In quel periodo stavo ancora disegnando Mask, la storia di Batman che avevo scritto per Archie Goodwin e la collana Legends of the Dark Knight. Finita quella, avrei dato la precedenza al “Topo cattivo”. Arrivo alla convention e mi presento allo stand Tundra, una cosa enorme. Ma lì mi prende lo sgomento, non solo per il gran numero di albi in catalogo, ma anche per la scarsa qualità media: pochi grandi titoli in un mare di robaccia. L’impressione è che pubblicassero qualunque cosa gli capitasse a tiro. Non volevo veder finire La storia del topo cattivo in un contesto tanto mediocre, così ho rinunciato all’incontro con Tundra, tentando la fortuna con Mike Richardson di Dark Horse, col risultato di godermi le ore di anticamera che la sua fitta agenda richiedeva. A suo merito, ha accettato il progetto sui due piedi, un bell’atto di coraggio da parte sua, dato che non assomigliava ad altro che Dark Horse avesse mai pubblicato.
Citavi Mask, il one-shot di Legends Of The Dark Knight in cui Batman è l’alter ego di un Bruce Wayne alcolizzato in preda al delirio. La storia di un topo volante cattivo, per così dire… cosa ricordi di quell’esperienza?
Mask è basato su un’idea avuta da adolescente, negli Anni ’60. Me n’ero ricordato una bella mattina del 1992. Per coincidenza, in quel periodo mi sono ritrovato a cena con lo sceneggiatore Archie Goodwin, fresco di nomina come editor della testata Legends of the Dark Knight. Gli raccontai la storia a grandi linee, e lui mi invitò a fargli avere una proposta. Ma ero convinto che non se ne sarebbe fatto niente, e li per lì me ne dimenticai completamente… Almeno fino a 6 mesi dopo, quando, rivedendolo, mi sentii chiedere “Che fine ha fatto quell’idea per Batman?”. Non solo non scherzava, ma pensava fosse un ottimo spunto. La settimana successiva mi misi al lavoro, e il resto è filato tutto liscio.
Una cosa che ho scoperto negli anni trascorsi a scrivere storie è che ogni lettore le vive a modo suo. Tanti lettori di La storia del topo cattivo mi hanno confidato di aver vissuto la lettura come un sostegno emotivo rispetto agli abusi subiti in gioventù. Con Batman è lo stesso: per alcuni si tratta di una semplice storia di super-eroi, per altri potrebbe avere un effetto terapeutico.
L’impressione è che nelle tue opere le fantasticherie siano un tema ricorrente. Da Luther Arkwright, a 2000 A.D., fino a Grandville, le visioni di mondi lontani sembrano essere la tua cifra stilistica: il che è buffo, considerando il tono serio di La storia del topo cattivo.
In realtà, ho scritto e disegnato altri due romanzi grafici non di genere: Alice in Sunderland e Metronome, più le cinque che ho disegnato su testi di mia moglie Mary, a cominciare da Dotter of Her Father’s Eyes, pubblicata in Italia da Nicola Pesce Edizioni (graphic novel che tratta il tema della malattia mentale della figlia di James Joyce Lucia, degente di un manicomio per trent’anni, ndr). Ma nel caso del “Topo”, le fantasticherie di Helen servono per fornire ai lettori un indizio sul potere della sua immaginazione che, come suggerisce l’omaggio a Beatrix Potter sul finale, la porterà a diventare in prima persona una scrittrice e un’artista.
Mentre ti documentavi per La storia del topo cattivo ti è capitato di incontrare persone che hanno vissuto le stesse esperienze della protagonista Helen? Cos’hai scoperto facendo ricerche sull’argomento?
Non appena la notizia che stavo lavorando sul tema è diventata di dominio pubblico, mi ha davvero stupito il numero di persone che mi hanno contattato per parlarmi degli abusi che avevano subito: si va da amici che conoscevo da anni a persone che ho incontrato alle convention… Erano tutti entusiasti che pubblicassi il libro, perché all’epoca l’argomento era quasi tabù e molti ex ragazzini vittime di abusi pensavano di essere gli unici ad aver vissuto queste drammatiche esperienze, quindi erano restii a condividerle per paura di non essere presi sul serio. Resta il fatto che è importante parlare di questi temi e far sì che la gente ne parli, in modo da rompere la cultura omertosa tipica di queste esperienze.
Cosa ti ha spinto a utilizzare personaggi reali come reference per La storia del topo cattivo?
Quando ho realizzato che quella che avevo tra le mani era una storia per un pubblico mainstream, lo stile del fumetto si è evoluto in una chiave molto più realistica rispetto a tutta la mia produzione precedente. Per facilitare la lettura a chi non ha l’occhio allenato ai fumetti, ho scelto deliberatamente la linea chiara. Poi ho cominciato a raccogliere reference fotografiche utilizzando amici e conoscenti come modelli e ambientando la maggior parte degli eventi in luoghi reali. Quando lavori su storie fantascientifiche o fantastiche, le licenze poetiche sono d’obbligo, ma nel caso di La storia del topo cattivo puntavo al massimo realismo.
Qual è il tuo metodo di lavoro? Dato che sei un artista “lento”, immagino che tu sia molto attento nello storyboard. Oppure parti dalla sceneggiatura?
Normalmente, impiego circa tre giorni per scrivere, disegnare e colorare una tavola. Parto sempre dalla sceneggiatura, visualizzando il tutto a mente senza passare da uno storyboard. Negli ultimi 15 anni, ho capito di poter saltare quello step passando direttamente al disegno.
Lo humour ha un ruolo molto importante nelle tue storie, anche una storia dai contorni drammatici come il “Topo” ha delle parti più leggere, per esempio quelle ispirate a Beatrix Potter…
Tutte le storie hanno bisogno di luci e ombre. Senza un costante contrappunto tra scene e dialoghi, si finisce per annoiare il lettore, che si tratti di un’avventura, una commedia o un racconto “ambizioso”. La monotonia stufa. Di mio, mi considero uno sceneggiatore abbastanza intuitivo: se c’è spazio per un po’ di humour, anche in una situazione drammatica, ce lo metto.
Pensi mai di tornare da Helen per un seguito di La storia del topo cattivo?
Circa 4 anni fa, avevo iniziato ad accarezzare l’idea di un sequel ambientato vent’anni dopo la fine dell’originale, con Helen diventata una scrittrice per bambini trentaseienne che fa amicizia con una giovane senzatetto. Ci ho lavorato fino ad accumulare una cartella di appunti sul tema, prima di rendermi conto che forse era meglio lasciar stare. Ho il timore che un sequel potrebbe guastare l’effetto dell’originale, soprattutto per il rischio di mostrare che la vita di Helen dopo La storia del topo cattivo non è tutta rose e fiori. Un abuso implica postumi psicologici che possono durare tutta la vita, e il seguito potrebbe dimostrarlo.
Parlaci dei tuoi prossimi progetti…
Sono a metà delle 177 tavole di un prequel di Grandville ambientato 23 anni prima e interpretato dal mentore dell’ispettore LeBrock, Stamford Hawksmoor, apparso nel quinto volume. Data l’ambientazione antecedente alla rivoluzione industriale e quindi allo steampunk della serie originale, sarà un’opera molto diversa. Non sarà ambientata in una Belle Époque alternativa, precederà l’Art Nouveau e avrà il sapore acquerellato e seppiato dei vecchi dagherrotipi, invece dei vistosi colori digitali di Grandville. Quindi, sì: un volume molto vittoriano, ambientato a Londra, tra carrozze e nebbia densa quanto zuppa di piselli, molto Sherlock Holmes.
Intervista a cura di Andrea Voglino – novembre 2023






 Calvin & Hobbes © Universal Press Syndicate 2023
Calvin & Hobbes © Universal Press Syndicate 2023